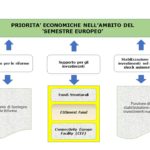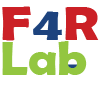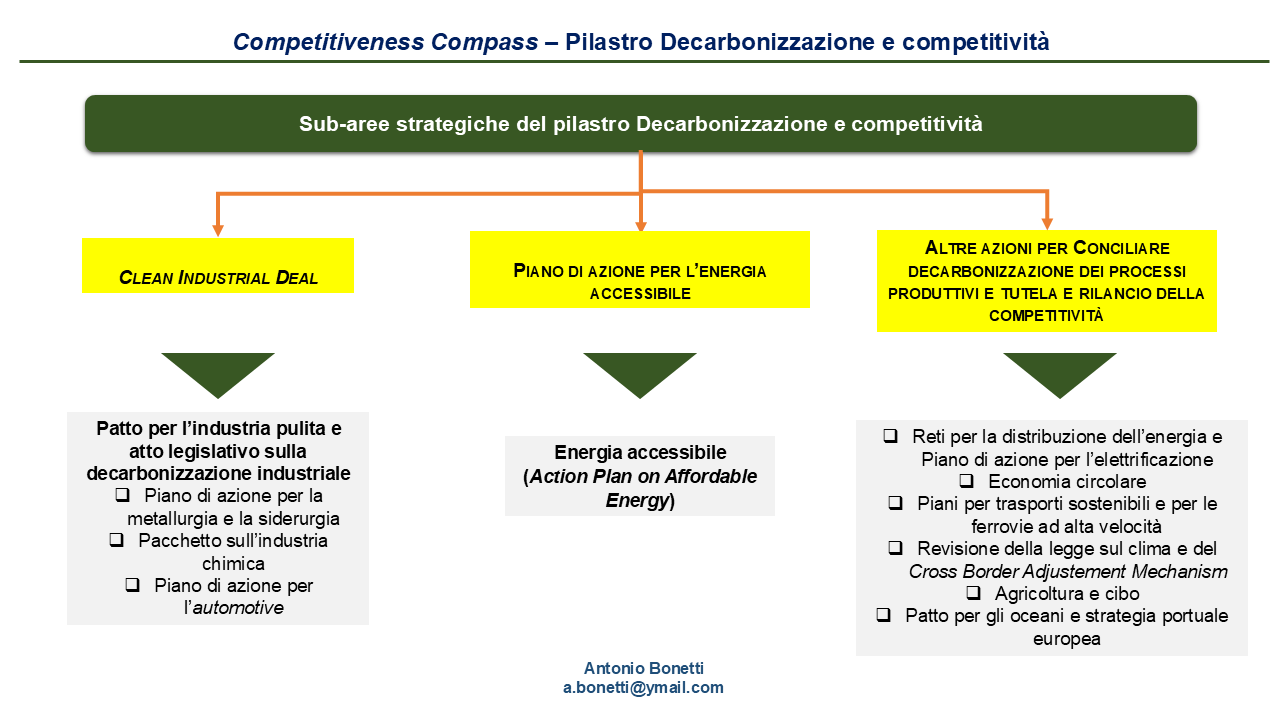Il post propone una intervista al professionista Federico Porcedda, affermato esperto di affari e fondi europei che ci presenta l’innovativo modello di europrogettazione eU-maps®.
Questo modello, come ci spiega meglio Federico Porcedda, “realizza l’integrazione delle due aree di conoscenza dell’euro-progettazione e del project management” ed è alla base del valido ed innovativo Corso Executive “Esperto in Progettazione e Gestione dei Fondi Europei” che inizierà il prossimo 5 aprile (la sede principale delle docenze frontali sarà l’Università Tor Vergata di Roma).